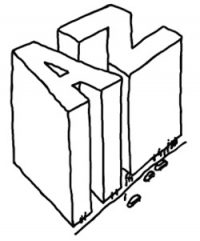Rubrica de “Il Sole 24ore” Abitare le parole / Talento – Nell’antica Grecia alla parola tàlanton (talento) venivano riconosciuti più significati: piatto della bilancia, peso; ma anche inclinazione (della bilancia), unità di peso e somma di denaro. Secondo quest’ultimo significato, ad Atene, il talento – moneta di metallo prezioso – corrispondeva a più di venti chili d’argento; quindi un’enorme ricchezza.
Tenendo sullo sfondo il significato di “enorme ricchezza”, la parola talento è passata a indicare sia la ricchezza di doti e di qualità che ornano una persona sia la persona che possiede questa ricchezza. Si può possedere un talento, ma si è anche un talento. In quest’ultimo senso l’utilizza C. Bene quando afferma che «Il talento fa quello che vuole, il genio fa quello che può».
Per chi crede, la varietà dei talenti è un dono che a piene mani Dio sparge tra i suoi figli. E comunque, di talenti, intesi come valore non monetario, si è provvisti naturalmente. Proprio per questo, se non c’è, il talento non si può imparare, riprodurre o copiare. Il talento posseduto può/deve essere però coltivato attraverso la cura delicata e continua; con la stessa pazienza con la quale il contadino accompagna la crescita di una pianta delicata. Il talento è un’inclinazione profonda e radicata. Più di una passione. È una qualità che si fonde con la personalità e, talvolta, con gli stessi tratti cromosomici.
Se coltivato, un talento ne sprigiona altri sopiti o nascosti; libera altre ricchezze da elargire, altre bellezze da contemplare. Ma se, come nella parabola evangelica (Mt 25,14-30) nascondiamo l’unico talento a nostra disposizione per paura di perderlo – nella migliore delle ipotesi per paura di sprecarlo – allora perdiamo l’opportunità di far esplodere la ricchezza che ci portiamo dentro: ciò che siamo, ciò che proviamo, ciò che possiamo realizzare, ciò che potremmo essere. «La paura che fa nascondere i talenti è la paura che fa nascondere sotterra la nostra intelligenza.
Quasi fosse attentato all’umiltà o arroganza dello spirito il pensare con la propria testa. Togliersi la testa, o per paura di pensare o per fatica di pensare, non è opera gradita né agli uomini né a Dio, che ha fatto dono dell’intelligenza ai suoi figli» (A. Casati). Coltivare i propri talenti è più faticoso che starsene in un cantuccio a preservare la propria inclinazione e la propria mediocre intelligenza; in una rassicurante ma chiusa prigione, al riparo da ogni incontro, incapace di mettersi in gioco con i propri sentimenti, con la propria intelligenza e con la propria operatività. Chi sceglie di vivere così merita l’amara constatazione del Divino poeta: «Intesi ch’a così fatto tormento, erano dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento» (Inferno, V, vv.37-39). L’alternativa al vivere immobili nel pensiero, quasi bastassimo a noi stessi, è il vivere in un continuo positivo tumulto fra ricerca e scoperta, fra capacità e fallimento, fra prove e conferme, onorando il proprio talento.