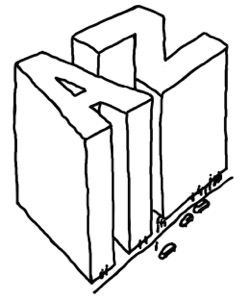Rubrica de “Il Sole 24ore” Abitare le parole / Potere – Un’attenzione all’articolata etimologia della parola felicità riduce il rischio di interpretazioni improprie di essa.
L’etimologia indoeuropea fa derivare la parola “Felicità” dal latino felicitas, derivazione di felix-icis (fecondo, fertile – e, in senso più lato – soddisfatto, appagato). Non va però ignorata la radice sanscrita bhu (trasformatasi in foe o in fe (abbondanza, ricchezza, prosperità) da cui il greco φύω, col significato di produco, faccio essere, genero; a sua volta all’origine dei termini fecondo e feto.
Già questi primi riscontri etimologici mostrano il limite di chi è portato a considerare la felicità come lo stato d’animo positivo di chi vede soddisfatti i propri desideri, e vive quindi nell’abbondanza e nella ricchezza, anche se non esclusivamente materiali.
Le dottrine morali dell’antichità classica, indicate come dottrine eudemonistiche, permettono di fare un passo avanti. Per i greci il concetto di felicità era espresso col termine eudaimonìa, composto da “eu” (bene) e “daimon” (divinità). Qui la felicità dipende dalla benevolenza del “daimon” e non dall’agire libero e consapevole dell’uomo. Per cui, felice è colui che ha la fortuna di avere la divinità dalla sua parte. Una concezione tutto sommato fatalista e quindi deresponsabilizzante, messa in crisi da chi, come Madre Teresa di Calcutta ritiene che “La felicità è un percorso, non una destinazione”. E, come in ogni percorso che si rispetti, “Non è vero che la felicità significhi una vita senza problemi; la vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà. Bisogna affrontare le sfide, fare del proprio meglio. Si raggiunge la felicità quando ci si rende conto di riuscire a controllare le sfide poste dal fato, ci si sente persi se aumentano le comodità” (Z. Bauman). O, come afferma K. Gibran: “Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno”. Proprio per questo starei alla larga da spiritualisti tristi e volontaristi impenitenti che tendono a far coincidere lo stato di felicità con l’agire in conformità a una norma. Della serie: felici perché osservanti. Conosco tanta gente osservante ma infelice, ligia ma insoddisfatta perché priva di libertà interiore e incapace di assumersi responsabilità; ingredienti previi e indispensabili per vivere in un duraturo stato di felicità.
Un aiuto in questa direzione può venirci dalla lingua latina, che ha tre termini per indicare l’essere felice: beatus, felix e laetus. Nel primo caso (beatus), la felicità è per lo più qualcosa che giunge dall’esterno. Invece, sia felix che laetus, hanno una etimologia simile che rimanda alla fertilità dei campi. In Catone, l’ager laetus (fecondo) è contrapposto all’ager siccus (sterile). Ma l’ager laetus, come lo stato di felicità, è dono ma è anche compito. E lo sappiamo, a rendere laetus (fertile) un campo contribuisce in maniera decisiva il lavoro costante e faticoso del contadino.
» Felicità